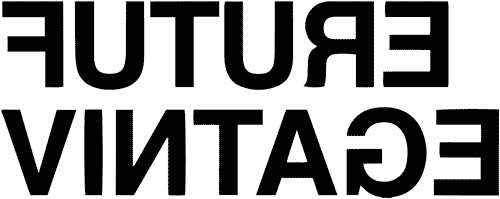Il reportage sugli incontri del secondo giorno del Vintage Festival 2013: cos’hanno detto i nostri ospiti? Ecco i riassunti e i punti salienti.
PHILIPPE DAVERIO
Nel presentare la sua ultima opera Satyricon Postmoderno Daverio ha esposto la sua visione della società in relazione all’arte e alla politica. La contemporaneità in cui ci troviamo è caratterizzata da un continuo confronto tra passato e presente, che inevitabilmente vengono a confondersi.
Siamo, per Philippe, di fronte ad uno scontro “epicoonirico” tra Trash e buongusto: la questione da affrontare oggi non è tanto quella di cosa possa insegnare l’arte quanto che cosa sia oggi definibile arte tout cour. Per esempio, Caravaggio fu definito da Borromeo un personaggio “non presentabile” per la sua eccentricità, e tuttavia si tratta forse di uno dei più grandi pittori che la storia ricordi.
O basta pensare ad un’affermazione legata ad un concetto estetico contemporaneo quale “che brutto sedere che ha quella!” in rapporto a quelli che erano i sederoni dipinti da Rubens. Emerge in questo caso la valenza antropologica del significato del binomio antitetico bello-brutto. Non solo il carico semantico cambia nel tempo e nello spazio, ma in ogni epoca –e oggi più di prima– tutto ciò che è bello lo è in quanto è stato codificato, in una continua standardizzazione dei comportamenti e dell’immaginario collettivo.
Insomma bello e brutto sono il risultato di un vero e proprio patto sociale. Daverio per spiegarlo ha proposto l’esempio del mascellone di Mussolini, e credo non potesse usarne uno migliore. Quando un’azienda di rasoi ha iniziato negli anni ’30 a usare testimonial mascelloni per dare maggiore smalto mediatico al prodotto, quasi che la prorompenza della mandibola mettesse a riparo da ogni dubbio sulla lama da acquistare, ecco che l’allora Socialista Benito ne ha fatto una nuova koinè, e di una caratteristica fisica che ha saputo ben sfruttare a livello mediatico.
Per capirci, tutto ciò che noi facciamo ha uno scarto di senso e di significato sempre ulteriore, e ciò vale sia per le immagini che per la parola, detta o scritta. Il congiuntivo, per esempio, se usato spesso e correttamente dà al proprio interlocutore un senso di sicurezza e pacificazione, ci fa sentire al sicuro. Che poi sia davvero così è un altro discorso. Avete mai sentito, per dirne una, quanti congiuntivi usa Berlusconi?
Ciò che davvero conta per Daverio è mantenere salda una prospettiva Utopistica, a mo’ di ideale regolativo, rendendo costante nel presente una sorta di “futuribilità”. Importante è il sapiente uso della dialettica storica, in un’epoca in cui si dibatte sull’esistenza definibile di una Postmodernità, tra una Modernità, di cui Daverio si fa sostenitore accanito, e una contemporaneità che vorrebbe annullare ogni tradizione, facendone tabula rasa.
Philippe Daverio ha capito bene cosa si intende con il termine Vintage.
«Viviamo in un’epoca che sarà identificata come l’epoca del trash: c’è una continua rivisitazione degli stili, ma in chiave grottesca e caricaturale, e dopo il trash ci sarà una nuova rivisitazione, probabilmente a carattere neoelitario. Cos’è il gusto? Boh.»
Chi inviterebbe Daverio, oggi, ad una fantomatica cena di Trimalchione? «La metà dei politici in parlamento, ma così facendo l’altra metà protesterebbe per non esser stata invitata.
Etica e morale, etimologicamente parlando, dovrebbero essere la stessa cosa, derivando rispettivamente da ethos e mos, moris, ma nella sostanza sono due cose ben diverse: l’etica prevede lo sbaglio, la morale no.»
«Io sono passato dall’essere socialista all’essere utopista: l’utopia non ha mai fatto male a nessuno. Ad esempio vorrei che la scuola dell’obbligo prevedesse per tutti una laurea in filosofia. Tutti a scuola fino ai 23 anni e poi, solo poi, si inizia a lavorare. Così si risolve il problema dei giovani senza lavoro, visto che saranno tutti a scuola, e quello dei pensionamenti, visto che si lavorerà fino ai 74 anni.»
«È necessaria la dialettica generazionale e il confronto continuo tra settantenni e venticinquenni: io voglio esser tolto di mezzo per rivoluzione, non per pensionamento.»
ANDREA PELLIZZARI
Muoversi attraverso i media proponendo progetti e concept di successo con ironia e professionalità. Andrea Pellizzari giunge in auditorium proprio per raccontarci la sua esperienza, un percorso lavorativo che ha lasciato il segno in tutti i mezzi di comunicazione.
Andrea Pellizzari è dj, conduttore radiofonico e conduttore televisivo. Conosciuto grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Le Iene, e come protagonista delle candid camera nei panni di Mr. Brown, ha iniziato la sua carriera radiofonica nel 1982.
Moderatore dell’incontro, Marco Bernar: alza potenziometri dallo scorso millennio. Da tastiere e monitor di Roxybar alla modulazione di frequenza e i flussi di bit di Sherwood, una vita votata a musica ed informatica che non gli fa disdegnare qualsiasi supporto o media che faccia vibrare anima, corpo o entrambi, basta che ci sia un mixer a decidere quando cominciare. La fine, al momento, non è prevista.
I meccanismi che portano alla variazione della funzione stessa di un grande media come la radio: una gradita lezione dall’esperienza di Andrea Pellizzari, che non si ferma alla monodimensionalità dell’informazione ma passa alla narrazione della genesi della sua carriera televisiva. Spunti notevoli che hanno fatto sembrare 60 minuti una velocissima ora d’aria, addizionata delle incursioni del collega Gip e dei suoi giovani opinionisti in auditorium. Concretezza e fine della passività da parte di ogni fruitore, davanti, dietro e dentro lo schermo: questa la ricetta per riprendere quota, oltre al controllo.
MAURIZIO REBUZZINI
Quest’anno Leica ha compiuto il suo primo centenario, e per festeggiare Maurizio Rebuzzini, Docente di Storia della Fotografia nonché fotografo lui stesso, ha ripercorso con noi la storia dell’azienza e di quello che è stato, dal 1913, un secolo di fotografia.
Le macchine fotografiche Leica non possiedono automatismi né autofocus, sono cioè molto difficili da usare, e fondamentale è l’idea di chi sta fotografando. Il Manifesto del 1947 presentava difatti la “think camera”, quella che funzionava solo grazie ad un’idea ben chiara dell’occhio posto dietro all’obbiettivo! Rebuzzini con ciò ha voluto spiegare quella che per lui è la condizione fondante della fotografia: un punto mai d’arrivo, ma di partenza per vivere e rivivere le nostre emozioni e i nostri entusiasmi.
La storia della fotografia è scandita da quattro momenti di rottura e innovazione assieme:
– la fondazione della Box Kodak (siamo nel 1888) che ha permesso, in quanto prima macchina portatile, di scattare foto-ricordo e i primi album di famiglia;
– la commercializzazione delle Leica con obbiettivi intercambiabili nel 1925, una vera svolta per gli addetti ai lavori;
– la nascita della Polaroid nel 1932;
– la prima macchina digitale brevettata da Sony nel 1981.
In questo arco di tempo la fotografia non solo si è tecnologizzata, ma, cosa più importante, si è progressivamente democraticizzata, divenendo strumento di più ampia fruizione per un mondo, quello borghese, svincolato dalla ritrattistica pittorica fino a qualche decennio prima dominante.
La storia di Leica è stata fatta dai fotografi che si sono identificati con le macchine dell’azienda: uno per tutti Cartier-Bresson, definito da Le Monde “l’Occhio del Secolo” nel 2004, anno della sua scomparsa. A Bresson è stata regalata una macchina unica, realizzata da Laica ad hoc con tanto di data di nascita del reporter come numero di matricola (è stata poi messa all’asta e devoluta in beneficenza, n.d.r).
«All’inizio Leica non ha avuto il successo che ora si vuole far credere abbia avuto» precisa Rebuzzini, proponendo una riflessione sul senso del passato di gusto Orwelliano «era comparsa in una mezza pagina di un catalogo genovese, il Cattaneo, quasi inosservata». Solo grazie al contributo di fotografi (dai grandi reportage al flannery- la foto a mano libera, in passeggiata) come Oskar Bamak, Berengo Gardini, Roger Fenton e Rodchenko è divenuta un vero e proprio fenomeno di massa.
Per concludere l’interessante appunto di Rebuzzini: «la fotografia più che dalla pittura dipende dal teatro: come in quest’ultimo c’è sempre uno iato tra realtà e illusione. È in questo piccolo spazio che trova posto il pensiero: ecco la magnifica illusione della fotografia».